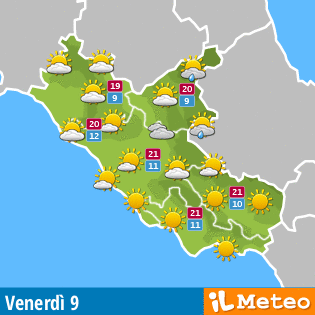La situazione grave in cui versano i Comuni Italiani, ed in particolare quelli di ridotte dimensioni demografiche, deriva da una criticità che prima di essere politica ed amministrativa, è culturale. Il nuovo Titolo V, che ha rappresentato il punto più avanzato del processo di crescita ed affermazione dell’autonomia e del ruolo del Comune, quale una delle componenti equiordinate della Repubblica, è rimasto inapplicato.
La situazione grave in cui versano i Comuni Italiani, ed in particolare quelli di ridotte dimensioni demografiche, deriva da una criticità che prima di essere politica ed amministrativa, è culturale. Il nuovo Titolo V, che ha rappresentato il punto più avanzato del processo di crescita ed affermazione dell’autonomia e del ruolo del Comune, quale una delle componenti equiordinate della Repubblica, è rimasto inapplicato.
Il Testo Unico degli enti locali, che agli articoli 4 e 5 apportava un profondo riequilibrio ai nuovi ed estesissimi poteri delle Regioni, solo in pochissimi casi ha avuto norme applicative; di qui l’esigenza di riformare la riforma che aveva riformato la legge quadro 142/90. Inoltre l’equiordinazione dei Comuni con Stato, Regioni, Province e Città Metropolitane, non ha dato luogo ad una revisione del sistema vigente dei rapporti istituzionali, incentrato sulla Conferenza Stato-Regioni e Conferenza Unificata, improntate alla primazia gerarchica dello Stato.
Nonostante quindi la Costituzione abbia previsto un passaggio di poteri (prerogative e risorse finanziarie) dallo Stato alle Regioni e da queste ai Comuni su un piano di perfetta parità e chiarezza istituzionale (chi fa che cosa), la politica tutta, impregnata di centralismo statuale in conflitto con il neocentralismo regionale, non ne ha dato corso. Anzi la situazione è peggiorata perché oggi al posto del federalismo e del decntramento, abbiamo due centralismi che si contrastano e si annullano, a spese dei territori.
La lezione millenaria dei Comuni e quella dei cento anni dell’ Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, le elaborazioni di decine di suoi esponenti, a cominciare da Luigi Sturzo, sono state misconosciute e talvolta tradite ed ora che ci accingiamo alla riforma della riforma della riforma non si può evitare un senso (mi verrebbe da dire nausea) di smarrimento.